Guida di web design per programmatori: come disegnare un sito web applicando le regole di UX/UI design


Ti avevamo già parlato della differenza tra web designer e web developer; tuttavia, ad oggi, le figure professionali del mondo digital spesso lavorano in una situazione di cooperazione e, perché questo avvenga nella maniera più proficua possibile, anche i web developers (soprattutto i frontend developer!!) necessitano di conoscere almeno i principi basilari dell’UX/UI design, al fine di progettare siti web funzionali.
Con questa guida scoprirai come muoverti quando progetti e disegni il layout di un sito web in soli 10 passi.
Cosa si intende per UX/UI design
È un termine, ad oggi, decisamente inflazionato: ma cosa vuol dire, esattamente, UX/UI design?
L’UX/UI design è un ramo del design che contempla due attori differenti: da un lato abbiamo l’UX designer, appunto, e dall’altro l’UI designer.
Dunque, nonostante si senta sempre più spesso parlare di UX/UI, l’ UI design e l’UX design non sono la stessa cosa; anche se, non di rado, i due ruoli vengono incarnati dalla stessa persona si tratta, infatti, di due ambiti differenti del processo di progettazione del design di un sito web che, tuttavia, operano in collaborazione con il fine ultimo di strutturare l’esperienza che l’utente avrà fruendo il sito nella maniera più ottimale possibile.
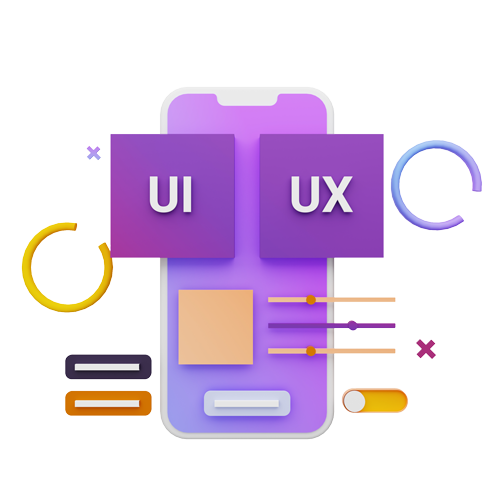
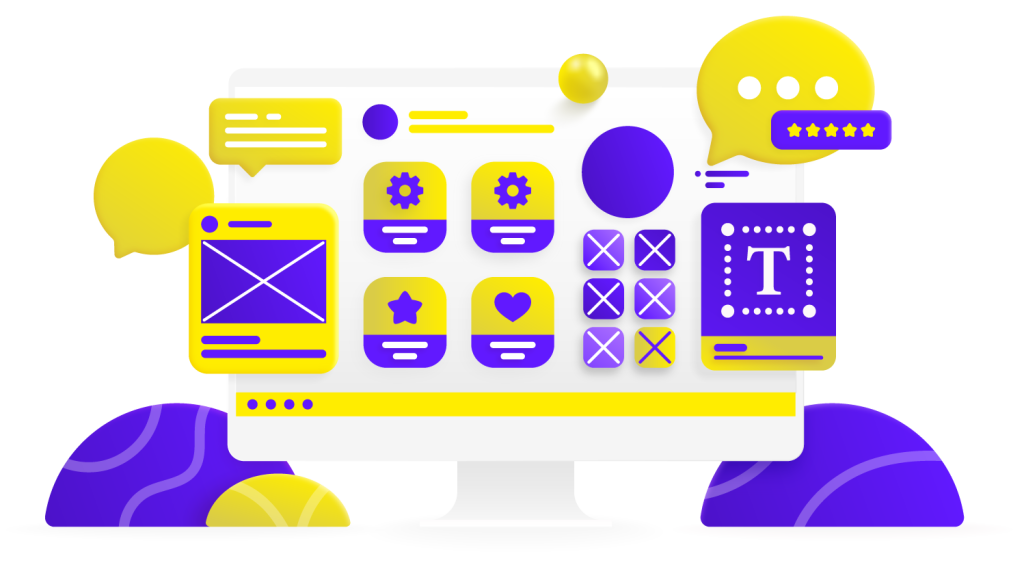
Cos'è l' UX design e cosa fa l'UX designer
L’UX design è una parte fondamentale della progettazione, ed è proprio da qui che ha inizio l’intero flusso della progettazione stessa: il focus è quello di progettare per la soddisfazione dei bisogni di chi utilizza il servizio o il prodotto.
L’UX designer cosa fa, dunque? L’UX designer mette in moto una fase di ricerca (User Research), in seguito alla quale potrà analizzare i dati ottenuti e, sulla base di questi, progettare uno o più prototipi “spogli” da far testare all’utente finale per verificare che la navigazione avvenga nel modo più semplice e soddisfacente possibile.
Cos'è l'UI design e cosa fa l'UI designer
L’UI design ha meno a che fare con la parte di ricerca e lavora concretamente sull’interfaccia che visualizzerà l’utente finale.
Cosa vuol dire? L’UI designer non prescinde dalla ricerca ma, sulla base delle informazioni ottenute dal lavoro dell’UX designer, converte il tutto in linguaggio visivo, realizzando la grafica vera e propria della schermata visibile all’utente.
Volendo fare un parallelismo con il mondo dello sviluppo web, (a grandissime linee: l’analogia è, ovviamente, riduttiva rispetto ai compiti di queste figure e a fini puramente esplicativi) è come se l’UX designer fosse il nostro codice HTML, e si occupasse, quindi, dello scheletro e della gerarchia semantica delle informazioni, e l’UI designer fosse, invece, il nostro linguaggio CSS, che si occupa della veste grafica.
Chiarite queste distinzioni fondamentali, andiamo a vedere come disegnare un sito web applicando le regole di UX/UI design!

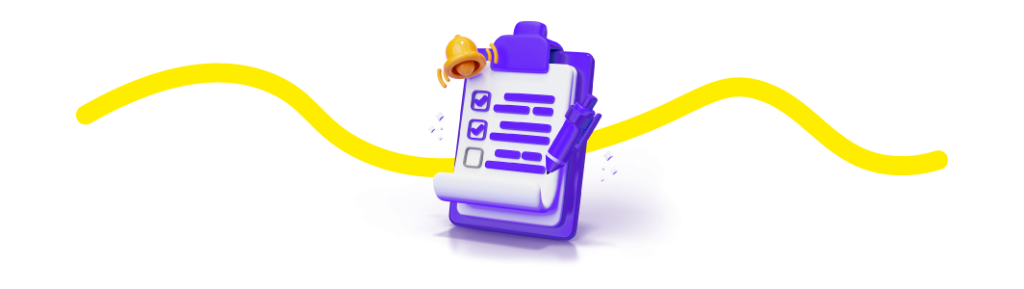
La prima cosa che dovrai fare per immedesimarti a pieno nel ruolo di UX designer quando dovrai creare un sito web da zero è partire da una fase di ipotesi.
Dovrai fare delle domande al cliente (in gergo, dovrai stilare un “brief”) che servano a:
-
Delineare quali sono gli obiettivi da raggiungere
con la realizzazione di questo sito: il raggiungimento di più persone? L’acquisizione di più contatti? L’aumento di vendite?
Ipotizza, quindi, quali possano essere i “business goals”; -
Delineare qual è il target
da raggiungere e a cui rivolgersi: il target non è altro che il gruppo dei potenziali fruitori del sito web; identificare il target è fondamentale nella progettazione del tuo sito perchè, così facendo, potrai adattarne il design e le modalità di fruizione in maniera tale che soddisfino proprio le necessità di quel gruppo di persone che ti interessa, andando a intercettare le loro preferenze;
-
Delineare i competitors:
devi individuare la concorrenza per poterla studiare.
Ci sono realtà che hanno realizzato qualcosa di simile a quello che stai realizzando, o che soddisfano le stesse necessità: analizzarle ti darà modo di ispirarti (attenzione, non copiare!!) per trovare le soluzioni adatte al tuo cliente e al tuo progetto; -
Delineare i problemi da risolvere:
quali sono gli effettivi problemi che la tua progettazione deve andare a risolvere?
È proprio a questo punto che devi cominciare a buttar giù le ipotesi: quali informazioni supponi di avere già?
Quali idee hai in merito agli utenti e alle loro necessità?
E come pensi di agire per soddisfarle?
Quali soluzioni hai in mente per la risoluzione dei problemi?
Come ultimo step di questa fase, dovrai analizzare (in maniera preliminare, si tratta pur sempre di ipotesi!!) tutti i metodi dell’ UX design e individuare quali di questi sono applicabili – in base, ovviamente, alle risorse disponibili – per sanare i bisogni emersi.
Ma quali sono i metodi dell’ UX design?
Tranquillo, te li mostriamo noi!
1.2 Quali sono i metodi della User Research
1.2.1 Ricerca quantitativa e ricerca qualitativa in UX design
Questi due tipi di ricerca sono complementari, si intersecano, si alimentano a vicenda, l’una può partire dai risultati dell’altra e non si sostituiscono l’una all’altra poichè hanno finalità diverse;
in particolare
I metodi della ricerca quantitativa
sono, banalmente, quelli che ci permettono di analizzare tutte le cose che sono quantificabili, misurabili con dei numeri.
Solitamente si utilizza la ricerca quantitativa su campioni di grandi dimensioni per delineare tendenze e rispondere a domande come, ad esempio, “dove l’utente si è fermato, nel flusso di navigazione?”, “quanti fruitori si sono fermati nello stesso punto?”.
Può essere utile, per esempio, a valutare il Bounce Rate.
Quali sono i metodi quantitativi?
-
A/B testing:
come il nome lascia facilmente immaginare, questo metodo consiste nel sottoporre due versioni diverse di una stessa pagina web con lo scopo di capire quale delle due è più funzionale agli obiettivi prefissati; al 50% del campione si sottoporrà la versione A della pagina, al restante 50% la versione B, in maniera tale da poter valutare quale versione sia più efficace
-
Questionari:
anche qui, il nome non nasconde molto: questo metodo prevede di sottoporre agli utenti una successione di domande al fine di raccogliere dati utili; strutturare questa serie di domande, tuttavia, potrebbe essere più difficile di quanto sembri: è necessario, infatti, evitare di influenzare l’utente, anche in maniera inconsapevole, generando le cosiddette “distorsioni” che portano a risultati non affidabili, vanificando il questionario. Il modo in cui viene posta la domanda, infatti, è molto importante, perchè può lasciare spazio a pregiudizi personali inconsci o a bias cognitivi, ma il modo in cui noi interpretiamo il mondo non deve intaccare l'intervista!
È, poi, utile, nei questionari, inserire domande di controllo - ovvero chiedere il contrario di quanto si è appena chiesto, per vedere se la risposta coincide - ed evitare domande alle quali l’utente possa rispondere in maniera secca “si” o “no”, poiché non sarebbero funzionali allo scopo. -
Test di usabilità non moderati:
i test di usabilità sono dei metodi della User Research con cui si valuta la capacità o l’incapacità dell’utente di portare a termine un obiettivo specificatogli, durante l’utilizzo di un prototipo del tuo sito.
Ci sono due tipi di test di usabilità, e sono quelli moderati e quelli non moderati; i secondi, che fanno parte dei metodi di ricerca quantitativa, non prevedono la presenza di un moderatore che faciliti il test mediante suggerimenti e script e sono svolti solitamente in modo autonomo mediante piattaforme online come Usertesting.com
I metodi della ricerca qualitativa
Sono quelli che, invece, fanno emergere i tratti più “umani” del campione e permettono di analizzare che sentimenti ed emozioni provano gli utenti e i loro pattern mentali: tutto ciò che non è quantificabile.
È utile, ad esempio, per misurare quali contenuti gli utenti preferiscano.
Quali sono i metodi qualitativi?
-
Ricerche etnografiche:
tutti quegli studi presi, appunto, dall'etnografia e dall’antropologia, che riguardano l’osservazione e l’immersione nella cultura di un determinato gruppo di persone per comprendere quali sono le loro abitudini e come spendono il loro tempo; è importante, in questo tipo di ricerca, mantenere costante un’apertura e un ascolto attivo non indifferenti, poiché la cultura delle persone cui è rivolto il servizio potrebbe differire dalla nostra e raccogliere informazioni nuove è un valore aggiunto notevolissimo per le finalità della ricerca
-
Interviste:
anche questo metodo prevede di sottoporre pochi utenti rappresentativi del nostro target ad una serie di domande circa un argomento di interesse specifico, per raccogliere, dunque, dati su quell’argomento.
Le interviste agli utenti, differentemente da altri metodi della User Research, sono svolte come sessioni individuali e sono strutturate come delle vere e proprie conversazioni in cui l’intervistatore segue uno script che si è preparato in precedenza e non devono durare troppo per non diventare tedianti; spesso retribuite, le interviste possono evidenziare i contenuti memorabili del sito e le migliorie da poter attuare. -
Test di usabilità moderati:
i test di usabilità moderati si distinguono dai primi per la presenza di un moderatore che segue la fruizione dell’utente sul prototipo e può guidarla, nonchè fare domande che permettano di scoprire cose che con i test non moderati non sarebbero mai emerse, perchè molto contestuali ("perché hai cliccato su quel bottone in particolare? Cosa ti aspetti?”)
1.2.1 Ricerca quantitativa e ricerca qualitativa in UX design
I metodi della ricerca comportamentale
sono applicabili quando abbiamo una cronologia da cui attingere: in presenza, cioè, di un sito web già online, già in utilizzo; in questi casi, l’UX designer si deve chiedere che cosa, nella situazione attuale del sito, funziona e cosa no.
E come può capirlo?
Analizzando come si comporta l’utente che naviga su quella piattaforma.
Quali sono i metodi comportamentali?
-
Eye-tracking:
L’eye-tracking è una procedura che monitora il movimento dello sguardo dell’utente; può sembrare fantascienza ma la spiegazione è piuttosto semplice. Viene utilizzata un’apparecchiatura che si avvale di una luce speciale che crea dei riflessi negli occhi della persona.
A quel punto, le telecamere del tracker e i sensori ottici annessi immortalano proprio quei riflessi e li usano per fare una stima del movimento degli occhi. Questi dati vengono, infine, proiettati sull'interfaccia, dando modo di far visualizzare dove l’occhio dell’utente si sofferma e per quanto tempo. -
Test di usabilità moderati
-
Test di usabilità non moderati
-
A/B testing
-
Click-stream analysis:
a click-stream analysis è una delle forme di tracciamento dei visitatori di un sito web che prevede il monitoraggio, e la successiva analisi, del flusso di click che l’utente attua nel visitare un sito web in modo tale da rilevare, ad esempio, quali sezioni del sito siano più visitate e quali percorsi facciano “più presa” sull’utente
i metodi della ricerca attitudinale
Sono utili per capire qual è l’atteggiamento dell’utente, i suoi pattern mentali e il suo pensiero rispetto alla user experience attualmente in auge.
È bene sottolineare che l’atteggiamento dell’utente e, dunque, ciò che dice e pensa, spesse volte non coincide con il modo in cui alla fine si comporta:
ecco la differenza sostanziale tra l’oggetto di indagine dei due tipi di ricerca.
Quali sono i metodi attitudinali?
-
Interviste
-
Diari:
i diari sono un metodo di ricerca estremamente utile quando vogliamo osservare i comportamenti degli utenti reiterati nel tempo, nel lungo periodo; la persona scriverà un diario dove registrerà tutto ciò che ha fatto cosicché i dati ottenuti non siano approssimativi ma realistici, e ricchi di dettagli inerenti anche all’emotività e ai sentimenti della persona nello svolgimento di determinate azioni
-
Card sorting:
il card sorting è un’attività molto semplice per capire come gli utenti ragionano e come collegano diverse categorie di cose in base a loro pattern mentali.
Consiste nel somministrare ad un gruppo di utenti dei cartoncini con sopra etichette categorizzanti, con la richiesta di suddividerli e ordinarli argomentando il ragionamento alla base delle scelte fatte; capire come è strutturata la logica del target è utilissimo per creare un'architettura dell'informazione che soddisfi le aspettative degli utenti -
Questionari
-
Focus group:
i focus group sono metodi di ricerca che riuniscono da un minimo di 6 ad un massimo di 9 utenti per farli discutere in merito a problemi e perplessità sulle caratteristiche di un'interfaccia utente, per la durata, in genere, di 2 ore circa, e sono gestiti da un moderatore che mantiene l'attenzione sul gruppo.
Con questa modalità di ricerca è facile che emergano reazioni e idee spontanee degli utenti ed è interessante come si possano osservare dinamiche relazionali e di gruppo.
Tuttavia, i focus group possono valutare solo ciò che i clienti dicono di fare e non il modo in cui i clienti utilizzano effettivamente il prodotto.
E, come ti abbiamo già spiegato, può esserci una grossa differenza tra ciò che le persone dicono e ciò che realmente fanno: per questo motivo i focus group vanno sempre integrati, magari con l’osservazione diretta e individuale degli utenti
1.2.3 Contesto d’utilizzo
L’analisi del contesto d’utilizzo prevede di raccogliere informazioni inerenti alle modalità in cui gli utenti campione utilizzeranno il sito web (o la piattaforma, in genere) nella ricerca; possiamo distinguere 4 modalità:
-
utilizzo naturale:
l'obiettivo di questa modalità è quello di ridurre al minimo le intromissioni nella ricerca, per comprendere il comportamento, appunto, naturale dell’utente, quello, cioè, il più vicino possibile alla realtà.
Se da un lato questo porta ad una maggiore validità esterna, dall’altro implica un minore controllo sugli argomenti trattati -
utilizzo scriptato:
questa modalità è utilizzata per focalizzare le intuizioni su aree specifiche della piattaforma, come, ad esempio, un flusso che è stato appena ridisegnato.
Il grado di scripting può variare molto, a seconda degli obiettivi della ricerca. -
utilizzo limitato:
questa modalità vede gli utenti campione testano una versione parziale o limitata del servizio, per esaminare un aspetto specifico dell'esperienza.
Ne è un esempio il card sorting visto prima, in cui il focus diventa su come l'architettura dell'informazione è o potrebbe essere organizzata per dare un senso facilitare la navigazione dei partecipanti -
utilizzo decontestualizzato
le ricerche in cui il prodotto non viene usato sono condotti per esaminare questioni più ampie rispetto all'uso e all'usabilità, come lo studio del marchio o la scoperta degli attributi estetici che i partecipanti associano a uno specifico stile di design.
Quali sono i metodi dell’analisi del contesto d’utilizzo?
-
Sondaggi
-
Interviste
-
Focus group
1.3 Come scegliere il metodo di User Research più adatto
Adesso hai ben chiaro in mente quali sono i metodi della User Research, ma, effettivamente, come capire quale di questi utilizzare?
L’ideale, come accennato già in precedenza, sarebbe utilizzare – in maniera ponderata e a seconda della casistica – una commistione di più metodologie.
Nonostante questa premessa, tuttavia, è naturale che i fattori che concorrono alla presa di decisione sono molteplici: prima di tutto occorre avere in mente la tipologia di esperienza utente da sviluppare, ma soprattutto le risorse a disposizione: budget del cliente, tool utili in possesso, grandezza del team di lavoro, limitazioni in termini di tempo come scadenze troppo brevi, ecc.
Tenendo bene a mente questi fattori, non ti resta che orientarti in base ai parametri sopra-citati!

La raccolta dati nell’UX design
Nella fase precedente hai buttato giù delle ipotesi: non dobbiamo essere certamente noi a precisare che non puoi basarti solo su quelle (non avrai mica scordato come funziona il buon vecchio metodo scientifico?), anche perchè rischi che i tuoi
bias cognitivi rovinino tutto il lavoro!
Pensaci: come puoi sapere se il target che hai ipotizzato nella fase precedente è quello giusto?
E come puoi avere la certezza che abbia realmente i bisogni che hai immaginato?
Non serve interrogarsi oltre: avrai già capito che è arrivata l’ ora, quindi, di avere dati empirici su cui lavorare.
Adesso sai come scegliere i metodi adatti, non ti resta che far partire la tua User Research!
Utilizza i metodi scelti e raccogli le informazioni emerse.
PS. Purché si tratti di informazioni aggiornate, puoi anche consultare la letteratura in materia, senz’altro ricca di analisi già esistenti ad aiutarti nella raccolta!
Un esempio per procedere nella raccolta dati, inerentemente, ad esempio, ai questionari, potrebbe essere estrapolare delle frasi dalle risposte degli utenti cui è stato posto il questionario; queste frasi andranno, poi, rielaborate (magari sintetizzate, ma sempre mantenendo fermo il concetto di base e, per quanto più possibile, il linguaggio della persona che ha risposto: rielaborare non deve significare snaturare la risposta!) per vedere se ci sono dei modelli comportamentali che tornano.
Distinguiamo, poi, tra queste, le cose che sono positive o che rappresentano un’ abitudine, e quelle che sono negative; a questo punto potremo procedere con il terzo step e andare a delineare le Personas.
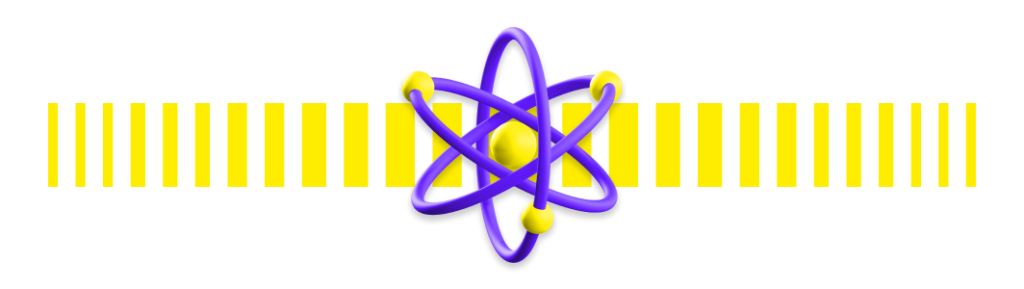
A questo punto cominciamo a fare sul serio: preparati, stai entrando nel vivo del tuo viaggio nel mondo dell’ UX/UI design!
Dati alla mano, non ti resta che analizzarli e provare a rispondere alle domande che avevi posto, all’inizio del tuo viaggio, al cliente.
Le risposte sono le stesse che avevi ipotizzato?
Che la risposta sia affermativa o meno, adesso dovresti sapere perfettamente:
-
qual è il tuo target di riferimento
-
quali sono i suoi reali problemi e le sue reali necessità
-
qual è il comportamento abituale del tuo target
3.1 Delinea le User Personas
Cosa sono le User Personas nell’ UX design
Una volta in possesso di queste informazioni, per rappresentare la tua target audience, dovrai delineare le User Personas.
Le User Personas (letteralmente traducibile con “personaggi”) sono delle rappresentazioni del nostro target di riferimento che cercano di essere affidabili e realistiche, nonostante siano “inventate” (attenzione: vengono create sempre basandosi su informazioni reali emerse con la ricerca e non sono MAI frutto di voli pindarici e preconcetti inconsci del designer!)
Le User Personas rappresentano, in altre parole, l’utente ideale di ciascun gruppo in target.
Per delineare le User Personas occorre essere incredibilmente specifici, poichè rimanendo troppo generici potremmo incorrere nell’abbracciare, all’interno dello stesso target, persone e personalità opposte (che, tuttavia, hanno delle cose in comune): per questo va delineata una Personas per gruppo di target emerso, magari uno antitetico all’altro.
Bisogna fare attenzione, inoltre, nella creazione delle Personas, a non lavorare eccessivamente per stereotipi: un esempio?
Ti verrà facile pensare che i vegetariani non mangino pesce: insomma, è carne anche quella, no?
Eppure, potresti stupirti nel venire a conoscenza del fatto che esistono vegetariani che il pesce lo mangiano eccome!
È per questo motivo che occorre basarsi sulle informazioni realmente emerse dalla User Research e non soffermarsi a procedere pensando a come la nostra mente elabora l’utente medio: la realtà è piena di diversità!
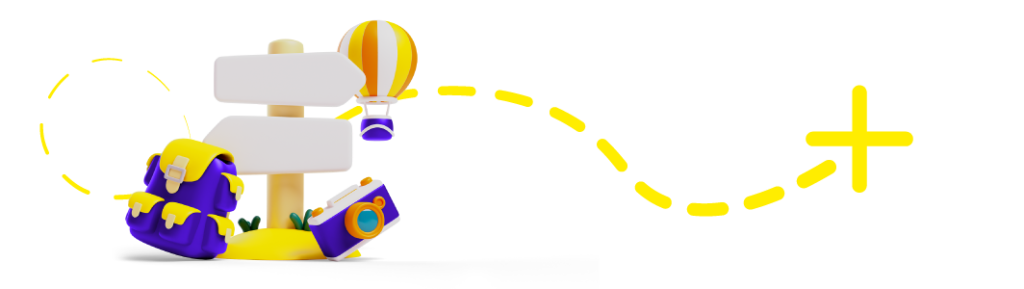
Che cos’è una User Journey nell’UX design
Ricapitolando, a questo punto hai delineato i gruppi di utenti in target e le relative User Personas, quali sono i reali problemi che dovrai risolvere e con quali funzionalità del sito poterlo fare; qual è lo step successivo?
Adesso dovrai Immaginare come le Personas interagiranno con il prodotto o il servizio che stai progettando, descrivendo quali sono i passi principali per raggiungere
l’ obiettivo e, soprattutto, focalizzandoti sui sentimenti e sulle emozioni della Persona durante il processo.
Tutta questa visione circa il viaggio che la Persona compirà nell’utilizzare il tuo sito web viene definita “User Journey”
Come realizzare una User Journey nell’UX design
Proviamo a darti qualche consiglio utile per disegnare l’User Journey facendoti un piccolo esempio:
potremmo immaginare un utente che, all’ora di pranzo, ha fame ma è a lavoro e non può cucinare; a questo punto, l’utente deciderà di ordinare del cibo; poi, l’utente aprirà la tua applicazione; a questo punto, l’utente ricercherà, nella barra di ricerca, del sushi; poi? Cosa succederà? Potrebbe essere che l’utente scelga di ordinare dal ristorante di sushi più vicino, così come che scelga, invece, quello con più recensioni positive o, ancora, che scelga semplicemente in base a quanti soldi aveva ipotizzato di spendere per quel pranzo; e via discorrendo.
Come potrai notare dall’esempio, lo User Journey è utilissimo per capire cosa pensa e cosa prova la persona durante il processo e ti aiuterà a definire i punti focali su cui agire e a delineare, dunque, tutte le soluzioni ai possibili problemi in cui il fruitore “inciamperà” nel corso della sua esperienza, nonché a definire sempre meglio la lista delle funzionalità che dovrà avere il tuo sito.
PS. Puoi realizzare uno storyboard per rappresentare meglio la User Journey!
Ti aiuterà, senza ombra di dubbio, a visualizzare meglio le azioni dell’utente all’interno del contesto in cui si trova, all’interno dell’ambiente vero e proprio in cui agisce e agli stimoli che ha intorno: tutti dettagli che magari, ipotizzando, non avresti considerato.
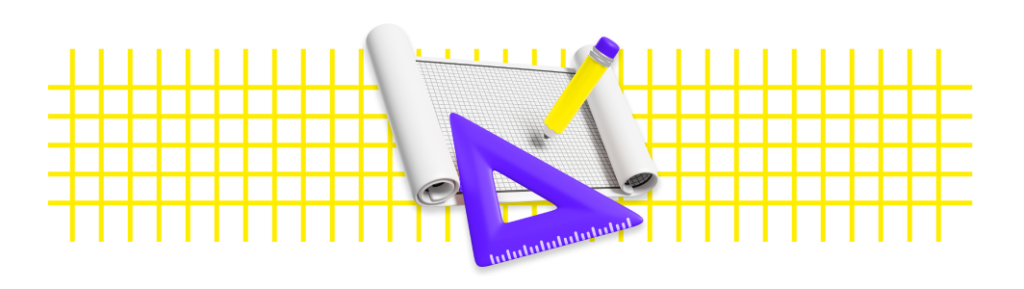
Dopo lo step dello User Journey sei stravolto: non hai mai avuto le idee così chiare in vita tua! Eppure ci sono ancora ulteriori step che possono aiutarti prima di passare alla parte un po’ più pratica.
È giunto il momento, infatti, di disegnare uno User Flow.
Che cos’è lo User Flow?
Lo User Flow nell’UX design è la visualizzazione del processo di come l’utente interagisce con il nostro sito web; per visualizzarlo al meglio utilizziamo i diagrammi di flusso che hanno delle freccette direzionali che fanno capire il senso del flusso; questi diagrammi conterranno vari elementi: l’ inizio, la fine, i punti di scelta: tutte queste situazioni vengono rappresentate per capire quali percorsi l’utente compie sul sito.
Questo ragionamento in modalità “Flow Chart” non ti sarà affatto nuovo se sei un programmatore informatico: è lo stesso tipo di ragionamento che si attua per istruire gli algoritmi!
Insomma, disegnando lo User Flow avrai finalmente una visione cristallina di tutte le azioni degli utenti sul tuo sito.
A questo punto c’è un’ultima cosa a cui devi pensare: progettare l’architettura delle informazioni.
Devi pensare, cioè, a come devono essere organizzate le informazioni del sito, creando una gerarchia dei contenuti e strutturando una navigazione logica: dove devi disporre gli elementi?
Come devi collegarli tra loro?
Ci raccomandiamo: nell’attuare questa operazione, l’obiettivo deve essere sempre una navigazione facile e ottimale per l’utente!
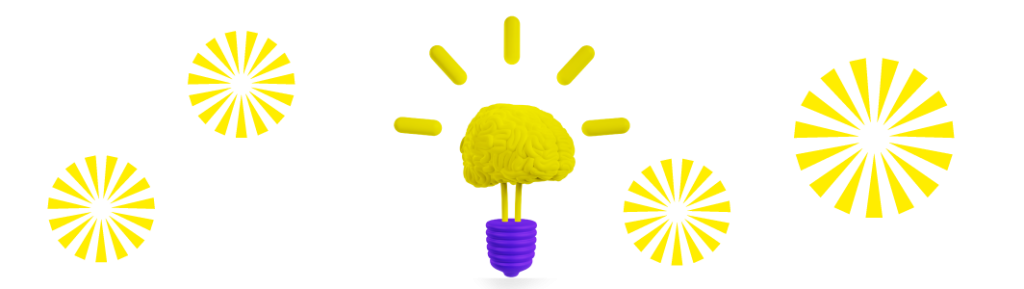
Sei finalmente nella fase di ideazione, durante la quale devi esplorare idee di design creative che possano risolvere i problemi dell’utente emersi nelle fasi di analisi precedenti: la generazione di idee può spaventare, soprattutto se sei uno sviluppatore web e non ti consideri particolarmente “creativo”.
In realtà – e questo ti stupirà – le idee non vengono stando li a pensare per ore ed ore fino allo stremo delle nostre forze.
Proviamo a spiegarti in maniera semplice come avviene la generazione di una nuova idea.
Ognuno di noi ha all’interno del suo cervello delle conoscenze, più o meno approfondite, inerenti agli ambiti più disparati, che puoi immaginare, per comodità, come dei pin di geolocalizzazione.
Cosa facciamo per produrre una nuova idea?
Cerchiamo di creare connessioni tra questi pin, che abbiano un senso, un valore, un perchè.
Certamente, se i pin sono molto vicini sarà più facile: in quel caso è possibile che l’idea sia un po’ banale (ma attenzione, non è detto che non sia funzionale!).
Se invece creiamo una connessione di valore tra due pin che si trovano agli antipodi, beh.. probabilmente l’idea a cui abbiamo pensato sarà brillante.
Adesso immagina di moltiplicare quei pin: aumentano, in proporzione, anche le possibili connessioni!
Quei pin possono aumentare, ovviamente, continuando ad esplorare, facendosi muovere dalla curiosità, approfondendo e analizzando tutto ciò che ci circonda e ci stimola (o, naturalmente, tutto ciò che è inerente al settore del cliente).
Un altro modo di aumentare quei pin, però, è quello di lavorare in team.
Se lavoriamo in un gruppo, la produzione di idee sarà particolarmente proficua, perchè le conoscenze pregresse di ogni membro del team saranno utilissime alla generazione di nuove connessioni tra i pin. Quello che andremo a fare sarà il cosiddetto brainstorming.
Sicuramente è un termine che avrai già sentito, ma ti rinfreschiamo la memoria:
il brainstorming è una tecnica (anzi, come vedrai, si parla di più tecniche) creativa per generare idee “su richiesta”.
Nonostante nell’immaginario collettivo il brainstorming sia, appunto, un’attività di gruppo, ci sono diverse tecniche per praticarlo anche se stiamo lavorando da soli.
Per uno sguardo rapido ad alcune tecniche di brainstorming (individuali o collettive) ti rimandiamo al blog di Grafigata!
Anche se nella fase precedente ti sono venute in mente delle idee di design eccezionali, dovrai tenerle un attimino ancora per te perchè, a questo punto del percorso per realizzare il layout del tuo sito web seguendo le regole di UX/UI, dovrai si, mettere le mani in pasta (finalmente!!) ma in una maniera alla quale probabilmente non avevi pensato.
Quello che devi fare, adesso, è realizzare un wireframe.
Che cos’è un wireframe nell’UX design
Un wireframe in UX design, è quello che viene definito un prototipo a bassa fedeltà.
In questa fase si crea una versione iniziale del sito che sia “spoglia”, priva di grafica, che permetta di visualizzare in maniera abbozzata, come fossero sketches, come apparirà lo scheletro del tuo sito (in questo punto ci sarà bisogno di un pulsante, in quest’ altro delle cards, e così via); durante questo processo dobbiamo cimentarci per semplificare il più possibile le cose all’utente: meno step possiamo fargli fare per raggiungere il risultato, meglio sarà; dobbiamo, ancora, assicurarci che non ci siano “punti di non ritorno” perchè magari abbiamo dimenticato di inserire un bottone, e via discorrendo.
Un tool particolarmente utile nella fase di wireframing è Miro, una piattaforma online costituita da una sorta di “lavagna” con la quale condividere il lavoro con i membri del team e poter lavorare anche in simultanea, molto utile anche nella fase di brainstorming!
Che cos’è un prototipo nell’UX/UI design
Il prototipo – che è, ovviamente, interattivo – serve a far vivere l’esperienza all’utente: serve a vedere, quindi, se le idee che avevamo progettato funzionano concretamente nella realtà.
Ma occhio, un prototipo serve a testare il prodotto, non a lanciarlo effettivamente nel mercato, perchè non sappiamo ancora se la nostra idea funziona e potremmo dover riformulare, correggere o addirittura ripensare alcune cose.
La realizzazione di un prototipo richiede, ovviamente, del tempo, ed è per questo che esistono due tipologie di prototipi:
-
wireframe:
vale a dire un prototipo a bassa fedeltà: te ne abbiamo parlato prima ma quello che abbiamo omesso è che, in effetti, puoi prototipare, a seconda del tempo disponibile, anche il wireframe stesso, rendendo interattive per l’utente determinate schermate;
-
mockup:
ovvero un prototipo ad alta fedeltà: questo tipo di prototipo è interamente funzionante, completamente interattivo, completo anche di una prima versione di interfaccia grafica
Nonostante nella teoria le due cose vengano distinte in due momenti separati, la verità è che nella pratica, ad oggi, spesso wireframe e mockup siano quasi una cosa che procede in simultanea (e spesso il wireframe ad oggi è anche evitabile, occorre solo se si ha necessità di far vedere in tempo brevissimo ciò che si sta facendo).
8.1 Come realizzare un prototipo in UX/UI design
I tool per creare un prototipo nell’UX/UI design
Partiamo col dire che esistono diversi tool per la prototipazione del tuo sito web e citeremo, in questa sede, quelli che vanno per la maggiore e che sono, ad oggi, tra i più utilizzati.
I tool che ci sentiamo di consigliarti in prima persona per la prototipazione del tuo sito web sono tre:
-
Figma:
Figma è un tool professionale di grafica vettoriale e di prototipazione online; realizzato nel 2015 sfruttando la tecnologia Web Assembly, non permette solo di realizzare interfacce grafiche ma di sbizzarrirsi in qualunque tipo di progetto grafico, dai post per i social alla realizzazione di presentazioni: non è un caso che, ad oggi, sia uno degli strumenti più apprezzati e usati nelle aziende di settore, tanto da essere stato perfino acquistato dal competitor Adobe.
Figma può essere utilizzato, proprio in virtù del Web Assembly, direttamente sul browser e permette al team di lavorare anche in tempo reale nello stesso momento, ottimizzando notevolmente i tempi.
È, inoltre, gratuito nella sua versione base (anche se, visti i recenti trascorsi con Adobe non sappiamo come potrà cambiare la situazione nel prossimo futuro).
Utilizzando figma ogni progetto viene salvato in maniera automatica nel Cloud; insomma, una vera chicca per il mondo del design digitale! -
Adobe XD:
acronimo di Adobe Experience Design, Adobe XD è, dal 2015, l’alleato di ogni web designer che disponga di una licenza singola o del pacchetto Creative Cloud di Adobe.
Questo significa che Adobe XD è un software a pagamento.
Come Figma, consente di creare interfacce utente e prototipi interattivi, e dispone, inoltre, della caratteristica dell’interoperabilità: come spiega Wikipedia, infatti “XD supporta e può aprire file da Illustrator, Photoshop, Photoshop Sketch e After Effects .
Oltre ad Adobe Creative Cloud, XD può anche connettersi ad altri strumenti e servizi come Slack e Microsoft Teams per collaborare.
Il software è in grado di regolare automaticamente e spostarsi senza problemi da macOS a Windows.
Per motivi di sicurezza, i prototipi possono essere inviati con protezioni tramite password per garantire la completa divulgazione.” -
Sketch:
Sketch è un software per la grafica vettoriale disponibile dal 2010, utilizzato, anch’esso, per progettare interfacce grafiche di siti e applicazioni mobile e, ad oggi, consente anche la prototipazione e la condivisione dei progetti.
Il “limite” di Sketch è quello di essere un software disponibile solo per macOS, tuttavia è ugualmente possibile visualizzare progetti realizzati in Sketch su altre piattaforme avvalendosi, però, di strumenti terzi per la conversione e analoghi.
Come accennato, possiamo etichettare questa triade di strumenti come i tool più in linea con le scelte aziendali al giorno d’oggi e, quindi, se il tuo obiettivo è entrare in azienda può essere una buona idea allinearti ed imparare ad utilizzare proprio uno dei tre.
Ovviamente esistono delle alternative e la scelta del tool da utilizzare resta strettamente soggettiva e personale.
Comincia a sperimentare!
Ci siamo: finalmente potremo sottoporre il nostro duro lavoro agli utenti.
Per valutare quanto funzionale e di facile fruizione sia il nostro prototipo dobbiamo, adesso, condurre dei test di usabilità con gli utenti, entrando nella cosiddetta fase di User Testing.
Questa fase ci consentirà di raccogliere feedback per individuare eventuali problemi e andare a risolverli prima ancora che il sito sia online!
9.1 User Testing: come fare un test di usabilità
Potresti pensare di dover far testare il tuo prototipo a centinaia di utenti: la verità è che, se i test sono condotti come dovrebbero, il numero di utenti ottimale è pari a 5.
Ma, di preciso, come dovrebbero essere condotti?
Vogliamo darti alcune tips utili per condurre al meglio questi test.
-
Dai un benvenuto amichevole:
le persone non devono sentirsi giudicate; non stai valutando quanto la persona sia furba, veloce nel ragionamento, intelligente nel cogliere determinate cose; stai valutando solo se il tuo prodotto funziona o no, quanto è comprensibile!
-
Fai delle domande circa il contesto di utilizzo:
hai progettato un e-commerce che vende abiti? Bzene: chiedi all’utente quante volte compra dei vestiti nuovi, perché, quali sensazioni sono legate allo shopping ecc.
L’utente così viene posto nel giusto mood e siamo facilitati nell’esecuzione del nostro User Test -
Introduci il prototipo raccontando il minimo indispensabile:
gli diamo le stesse info che otterrebbe guardando, ad esempio, una sponsorizzata; dobbiamo chiedergli di pensare ad alta voce perchè ci darà informazioni utilissime per capire come sta ragionando l’utente.
-
Dai dei task dettagliati e formulati in maniera semplice, da far compiere all’utente:
il prototipo non è l’intero sito, è limitato!
Quindi l’utente deve sapere che l’obiettivo da raggiungere navigando in quelle schermate è, ad esempio, aggiungere ai preferiti l’abito che preferisce (anche se, magari, dal prototipo non avrà la possibilità di arrivare alla procedura di pagamento); -
alla fine dell’intervista fai un piccolo debrief per aiutare l’utente a sviscerare meglio le sue reazioni con domande - sempre poste in maniera gentile - circa, ad esempio, le modalità in cui descriverebbero questo servizio ad un amico.
-
Rimani aperto:
non ti diremo una bugia, i feedback sul tuo lavoro in fase di testing potrebbero innervosirti; devi essere pronto a cogliere ogni suggerimento utile senza scaricare quella frustrazione sull’utente e sulla sua capacità di ragionamento.
Ora che hai tutti questi elementi e hai verificato che il tuo sito garantisce una navigazione funzionale, puoi finalmente svilupparne l’interfaccia grafica seguendo le regole della comunicazione visiva!
Anche qui, vogliamo darti qualche consiglio utile.
UI Design: come creare un'interfaccia utente efficace
Quando ci approcciamo alla creazione effettiva di un’interfaccia grafica, dobbiamo sempre tenere presente che la chiave deve essere la semplicità: dobbiamo cercare di rendere ciò che potrebbe essere complesso quanto più comprensibile possibile per l’utente finale.
L’obiettivo deve essere permettere all’utente di raggiungere il suo obiettivo con il minor sforzo possibile: l’utente non deve pensare, deve agire nella maniera più naturale possibile.
UI design: i principi fondamentali per una corretta interfaccia grafica
-
Coerente:
i componenti che hanno un aspetto simile devono avere anche un comportamento simile; questo comporta che, se l’utente ha appreso come funziona il primo componente (o la prima interfaccia) non avrà alcun tipo di problema nell’utilizzare le altre dall’aspetto similare, perchè sarà familiare e avrà già assimilato il pattern di funzionamento.
In caso contrario l’utente si sentirà spaesato e confuso e non riuscirà a procedere in maniera fluida nella navigazione. -
Visibile:
questa caratteristica potrebbe confonderti: insomma, è ovvio che qualcosa di presente sull’interfaccia grafica di un sito web sia visibile, no?
Il significato, però, è un po’ più sottile.
Quando parliamo di visibilità nel contesto dell’ UI design, ci stiamo riferendo al fatto che i componenti che pilotano le interazioni devono essere ben visibili, deve, quindi, essere ovvio che per raggiungere l'obiettivo in questione, occorrerà, per fare un esempio, premere quel determinato bottone.
L’interfaccia deve guidare l’utente, in maniera spontanea, all’interazione sul sito. -
Prevedibile:
l’utente deve essere in grado di prevedere che cosa comporterà un’azione durante il flusso di navigazione sul sito prima ancora di attuarla concretamente; se l’utente che naviga su un e-commerce vede l’icona cliccabile di un carrello, si aspetterà che, cliccandola, arriverà alla pagina dedicata, appunto, al carrello, con un riepilogo di tutti gli articoli che ha, eventualmente, aggiunto nel suo flusso di navigazione e avrà la possibilità di procedere al pagamento o di tornare indietro.
-
Responsive:
ti avevamo già parlato dell’importanza di progettare un layout responsive nella nostra guida html e css online e lo ribadiamo ancora una volta: ad oggi, il traffico sui siti web avviene principalmente da mobile e si prevede che, entro il 2025, la percentuale di utenti che fruiscono siti web da dispositivi mobile aumenterà notevolmente.
Proprio per questo, quando realizzerai l’interfaccia grafica di un sito web dovrai concepirla, prima di tutto, “mobile-first”, ovvero realizzarne il layout fruibile, in primo luogo, dallo schermo di un cellulare, procedendo poi verso la progettazione desktop.
La capacità di un’interfaccia di adattarsi alle dimensioni dei diversi schermi di fruizione è definita, appunto, responsive ed è una caratteristica indispensabile per una corretta interfaccia.
Alcuni principi base della comunicazione visiva
Ci sono, inoltre, dei principi basilari della comunicazione visiva – in genere – da considerare nella creazione di un’interfaccia grafica performante, che proviamo, ora, a declinare nel caso specifico dell’ UI design:
-
Gerarchia:
quando parliamo di gerarchia visiva ci riferiamo a quanto importante alcuni elementi di un’interfaccia grafica appaiono in relazione ad altri.
Devi quindi, cercare di definire quali siano le informazioni primarie, quali le secondarie e via discorrendo.
Ci sono diverse modalità per dare importanza ad un contenuto sulla tua interfaccia: la prima che potrebbe venirti in mente, in merito, magari, ad informazioni di tipo testuale, potrebbe essere la dimensione del font.
Questo non è un errore, ma devi tenere bene a mente che non occorre una sproporzione eccessiva ed esagerata delle dimensioni di un testo per dargli enfasi, ed esistono altre strategie per ottenere lo stesso risultato, attraverso, ad esempio, il colore o il peso del font utilizzato.
In alcuni casi potrà capitare di non avere ulteriori strategie per aggiungere enfasi agli elementi desiderati: la soluzione potrebbe essere cercare di capire come toglierla, invece, ai restanti meno importanti -
Spazi:
i contenuti in un sito web devono avere “respiro”.
Se gli elementi del sito sono troppo vicini e attaccati l’un l’altro, la percezione sarà quella di un qualcosa di caotico e soffocante, oltre che esteticamente poco piacevole.
Prova a concepire, in partenza, degli spazi bianchi notevolmente ampi, e riducili, via via, finché non ci sarà semplicemente “abbastanza” spazio.
Non hai bisogno di riempire l’intera schermata: solo perché hai, ad oggi, tutto quello spazio, ad esempio, da desktop, non significa che tu debba utilizzarlo tutto! -
Colori:
la palette colori da utilizzare nella realizzazione dell’interfaccia di un sito web dovrebbe prevedere al massimo 5 colori; non è un caso, che molti tool per generare palette di colori online contengano proprio 5 tinte.
La verità è che queste tinte vanno comunque sempre utilizzate con criterio, per non appesantire troppo il tutto e, soprattutto - e questo potrebbe stupirti - potresti aver bisogno di più colori di quanto esplicato fino ad ora? Cosa vuol dire?
Significa che, per realizzare qualcosa di effettivamente efficace, potresti aver bisogno di usare dei gradienti per cose alle quali non avevi pensato, ad esempio per facilitare la gerarchia visiva di cui sopra.
Per definire testi più importanti di altri, ma meno importanti dei principali, ad esempio, potresti dover utilizzare diverse tonalità del grigio!
Questo vuol dire che, per il colore principale - il primary color - per il colore neutrale - neutral color - e per i colori di accento - gli accents color - dovrai definire delle “sfumature” (bada bene, non intese come i gradient del mondo dello sviluppo web che hai imparato a conoscere bene, ma come singole tonalità!) diverse, da utilizzare al bisogno.
Quello dei colori è, naturalmente, un universo vastissimo, per questo, per approfondire, ti suggeriamo di leggere gli articoli sul colore di Grafigata articoli sul colore di Grafigata, per spunti interessanti sull’argomento. -
Immagini:
come ti sarà facile immaginare, le immagini giocano un ruolo importantissimo nel design della tua interfaccia: usare brutte immagini rovinerà il tuo sito, anche se il resto è stato realizzato in maniera egregia.
Non abbiamo la pretesa che tu assuma un fotografo per realizzare il sito ma, se ti rendi conto che le foto fornite dal cliente non sono esattamente di buona qualità, puoi sempre ricorrere ai siti di immagini di stock: scavando online, troverai facilmente siti di stock a pagamento, ma anche piattaforme gratuite con risorse davvero notevoli: alcuni esempi possono essere Unsplash e Pexels.
Un altro consiglio utile per l’utilizzo delle immagini del tuo sito, è tenere presente i contrasti: se nell’header, ad esempio, deve apparire un title o una scritta qualsiasi, tieni presente che la leggibilità, se non c’è adeguato contrasto, sarà irrimediabilmente compromessa!
In quei casi, la soluzione potrebbe essere quella di aggiungere un overlay semi-trasparente, che scurisca l’immagine di background e renda il testo effettivamente leggibile.
Letture interessanti: i libri imperdibili per un UI/UX designer
Non potevamo che concludere questo excursus con una lista di libri must-have per ogni UI/UX designer ma anche per ogni web developer (o aspirante tale!) che sia abbastanza desideroso di realizzare siti web altamente performanti e di piacevole fruizione:
-
Dont'make me think:
da quando Don’t Make Me Think è stato pubblicato nel 2000, centinaia di migliaia di web designer e sviluppatori web hanno fatto affidamento sulla guida all’usabilità del guru Steve Krug per comprendere i principi della navigazione intuitiva e della progettazione delle informazioni.
Arguto, ricco di buon senso ed estremamente pratico, è uno dei libri più amati e consigliati sul web design.
Ora Steve torna a riesaminare sotto una nuova prospettiva i principi che hanno reso Don’t Make Me Think un classico, arricchendolo con esempi aggiornati e un nuovo capitolo sulla usabilità mobile.
Ed è sempre un libro leggero, riccamente illustrato e, soprattutto, divertente da leggere.
Se hai letto la precedente edizione, ritroverai cosa ha reso Don’t Make Me Think così importante per i web designer e gli sviluppatori di tutto il mondo.
E se non l’hai fatto, capirai perché così tante persone hanno detto che è una lettura indispensabile per chiunque lavori nel settore della creazione di siti web. -
Manuale di sopravvivenza per UX designer:
dopo aver letto il “Manuale di sopravvivenza per UX designer” sarai equipaggiato di nozioni, tecniche e atteggiamenti per affrontare a viso aperto un qualsiasi progetto di user experience design nella vita reale.
Una guida pensata per professionisti del settore creativo, graphic designer, product designer e art director – ma anche imprenditori, startupper, project manager e web developers – che hanno bisogno di comprendere e applicare il processo di UX.
Grazie a questo manuale potrai resistere (e combattere!) nel mondo del lavoro vero, fatto di clienti con idee poco chiare e spesso privi di budget adeguati, direttori creativi che gridano e lanciano sedie per la stanza, e advisor poco qualificati che usano acronimi a sproposito e portano le startup del tutto fuori strada.
È uno strumento concreto e versatile: trasmette metodologie pratiche e racconta situazioni realmente vissute in cui è facile identificarsi, e ti aprirà tutte le porte della progettazione per l’utente. -
Mobile Design:
nomen omen, Mobile Design è un manuale utilissimo che si focalizza proprio su tutto il processo dell’esperienza dell’utente quando questa avviene da mobile; risorsa indispensabile in un mondo in cui i contenuti vengono visualizzati sempre di più dallo schermo di un cellulare!
-
User eXperience design. Progettare esperienze di valore per utenti e aziende:
progettare esperienze coinvolgenti e significative è una condizione fondamentale per differenziarsi dalla concorrenza, soddisfare i clienti e, di conseguenza, raggiungere gli obiettivi aziendali.
Aziende e professionisti dimostrano sempre più interesse per il design delle esperienze, e questo libro fa finalmente chiarezza sulla disciplina, ne fissa le basi e ne dà una visione completa e concreta.
User eXperience Design spiega come un approccio human-centered consenta di individuare soluzioni desiderabili per le persone, realizzabili tecnicamente e profittevoli per le aziende.
Nel contempo, illustra passo dopo passo un processo di progettazione che conduce alla scoperta di strade innovative, iniziando dalla individuazione del problema da risolvere.
Il libro descrive tutte le fasi di lavoro con le relative attività da svolgere e fornisce strumenti pratici, alcuni scaricabili dal sito www.uxlab.it. Gli elementi della strategia di UX design proposti nel libro si basano su un requisito imprescindibile: il coinvolgimento di utenti e aziende, necessario per ideare e testare soluzioni e costruire esperienze di valore.
Oggi design, marketing e business sono chiamati a collaborare per dissolvere le divisioni aziendali, adottando una visione condivisa, olistica e omnicanale dell’esperienza utente, e User eXperience Design sposa questo approccio, dimostrandone la validità.
Grazie a questa guida pratica e completa sullo UX design, la prima in italiano, imprenditori, manager e designer possono capire e sfruttare il grande potenziale del design per progettare prodotti e servizi in grado di fare la differenza. -
La caffettiera del masochista: Il design degli oggetti quotidiani:
non poteva mancare nella nostra lista un evergreen nelle classifiche dei libri per chiunque voglia approcciarsi al design; La caffettiera del masochista è IL libro capace di dare un perchè a tutte le volte che, in vita tua, hai tirato quella porta invece che spingerla. Illustra, con esempi enormemente esaustivi del mondo quotidiano, che cos’è il design, spacciato troppo spesso, erroneamente, per una materia atta a rendere esteticamente bello qualcosa: il design, invece, ha l’obiettivo di creare oggetti e servizi funzionali, che semplifichino e migliorino la vita delle persone.
Nonostante la prima edizione risalga al 1988 e si può, quindi, pensare ad esempi un po’ datati, una nuova edizione, rivista e ampliata, è stata rilasciata in Italia nel 2019.
Impossibile privarsi di questa lettura!
Sei pronto a iniziare questa nuova avventura?
Adesso sei pronto per creare il tuo primo sito web applicando le regole dell’ UX/UI design!
Speriamo che questa guida possa esserti stata di aiuto e possa aver stimolato la tua curiosità e il tuo interesse verso questo mondo.
Naturalmente, si tratta di un’infarinatura e i temi trattati possono essere approfonditi.
Non vedi l’ora? Perfetto!
Abbiamo strutturato per te un corso di Web Design
Cosa aspetti? Iscriviti!


