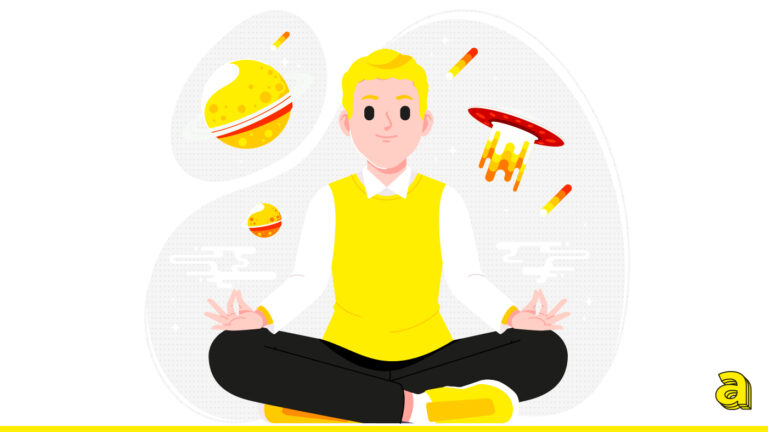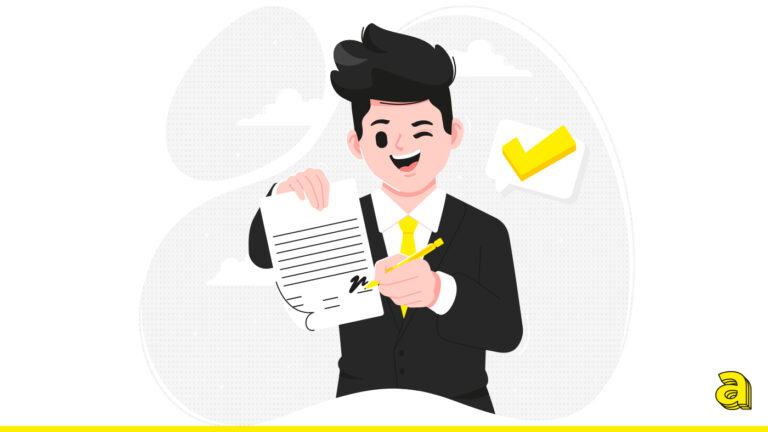Hai mai pensato alla prima volta che ti è stato chiesto cosa volessi fare da grande? Capita spesso, nel formulare la risposta, di tentare di accontentare entrambi gli emisferi del nostro cervello, cercando un rapporto aureo tra pensiero creativo e quello analitico.
Nell'antichità, il rapporto tra queste due aree era sicuramente più riconosciuto e diffuso che adesso. La capillare specializzazione che è stata protagonista di tutta la cultura formativa del Novecento (e che, citando Robert Einlein, "va bene per gli insetti"), a sua volta figlia della rivoluzione industriale, ci ha portato ad interrogarci sin da piccoli su quale sia la nostra vocazione professionale. Chiaramente, crescendo ci si trova a fare i conti con la realtà e con le opportunità lavorative che concretamente ci si presentano; per questo, prima di intraprendere un percorso nell'ambito della programmazione informatica, è sensato porsi alcune domande.
La programmazione informatica fa per me?
Per capire se questa professione è adatta a noi, prima ancora di capire quali siano le competenze da acquisire, dobbiamo interrogarci su quali qualità umane (dette anche soft skills) siano determinanti nel fare di noi dei buoni web developer.
Tralasciando tutto ciò che riguarda le dinamiche di gruppo e il lavoro di squadra, individualmente dobbiamo, sicuramente, andare a ricercare almeno una di queste due qualità:
- la capacità di avere idee e intuizioni per risolvere un problema;
- la capacità di formalizzare e concretizzare le soluzioni.
Ovviamente, si tratta di qualità complementari che nessun essere umano può vantare in maniera spiccata e perfettamente bilanciata; d'altra parte, è sostanzialmente impossibile esserne completamente privi. La scienza moderna spiega che queste capacità risiedono rispettivamente negli emisferi destro e sinistro del cervello, questa specializzazione è chiamata lateralizzazione delle funzioni cerebrali.
Rivitalizzare il corpo calloso
I mancini sono fortunati. Non certo nell'uso di oggetti comuni come forbici, coltelli, videocamere, telefoni (sì, anche i telefoni), penne e matite… No, non da quel punto di vista. Neurologicamente parlando, il cervello dei mancini presenta un più ampio corpo calloso, cioè quel fascio di fibre nervose che connette i due emisferi. Da un punto di vista pratico, questo comporta un maggiore traffico di informazioni tra pensiero analitico e pensiero creativo.
Indipendentemente dall'essere mancini, possiamo fare molto per incrementare questo traffico di informazioni ed intrecciare bene analisi e intuito, metodo e improvvisazione. Semplificando brutalmente la realtà, consideriamo la tecnica appannaggio dell'emisfero sinistro, e la creatività una dote esclusiva dell'emisfero destro.
Cominciamo affrontando separatamente questi due campi.
Che cos'è la tecnica
Ironicamente, la parola tecnica viene dal greco e significa arte, ma non nel senso che intendiamo oggi, bensì con il significato di capacità di fare. Quindi, non l'arte dell'artista, ma più quella dell'artigiano: se vogliamo, la maestria, la padronanza di tutte le norme che regolano una determinata mansione. Nel momento in cui si parla di norme e regole, evochiamo il pensiero analitico dedito al rigore, alla logica e al linguaggio, inteso come capacità di astrarre, simbolizzare e formalizzare.
Nel concreto, la tecnica si acquisisce principalmente in due modi:
- Esperienza: non richiede formazione preventiva; di fatto, l'esperienza non è altro che il registro degli esiti di tutti i tentativi che facciamo per ottenere qualcosa.
- Studio: banalizzando, lo studio non è altro che l'acquisizione dell'esperienza altrui, somministrata sotto forma di nozioni formali, cioè tramite il linguaggio.
In definitiva, la tecnica deriva sempre, direttamente o indirettamente, dall'esperienza, di cui è una formalizzazione. Pensiamo a cosa fa un istruttore di sci quando ci trasmette il seguente concetto:
"Punte a monte ti fermi, punte a valle vai". (cit. istruttore di sci).
Non sta, forse, sintetizzando in una nozione il risultato di una serie di tentativi fatti dall'uomo, sin da quando a qualcuno è venuta l'idea di mettersi delle slitte sotto ai piedi e pattinare in discesa sulla neve?
Fin qui abbiamo parlato solo di teoria, ma se la tecnica è arte e maestria, senza pratica non andiamo da nessuna parte. Entra in gioco l'esercizio.
Il ruolo dell'esercizio nello sviluppo della tecnica
"Repetita juvant" (proverbio latino).
"Siamo quello che facciamo ripetutamente". (Aristotele, ma anche The Edge, uno dei boss del bellissimo gioco Furi).
L'esercizio è l'applicazione ripetuta di una competenza. Lo scopo primario dell'esercizio non è quello di acquisire nuova conoscenza, ma di interiorizzare e perfezionare le competenze favorendo l'acquisizione di esperienza.
L'esercizio coincide col risolvere una serie di problemi fittizi di difficoltà crescente. Prova a pensare all'esercizio del ragno, che si fa fare a tutti i principianti chitarristi. Un esercizio massacrante per i poveri allievi, ma determinante nel far sì che il suonatore "prenda la forma" dello strumento e possa dunque suonarlo. Idem per il famigerato e dolorosissimo barré.
Visto che siamo ancora nell'area analitica dei nostri cervelli, è evidente che il processo di sviluppo della tecnica è mediato da un metodo, cioè una sorta di guida operativa che garantisce il buon esito della nostra esecuzione.
Ora, attraversiamo il corpo calloso e andiamo dall'altra parte.
Che cos'è la creatività
La creatività è un concetto relativamente recente: la parola creatività è entrata nel lessico italiano solo negli anni Cinquanta. Per creatività si intende l'attitudine mentale a produrre idee e invenzioni, apparentemente "dal nulla". In realtà, al posto di "produrre" dovremmo dire "far emergere" e, invece che "dal nulla", dovremmo dire "dalle simulazioni che il nostro cervello fa inconsciamente tutto il tempo".
La spinta esploratrice
Sì, perché la creatività è connessa all'emisfero che si occupa anche dell'orientamento e della percezione dello spazio. Non è un caso che durante i viaggi ci si senta sempre molto ispirati: l'emisfero destro del nostro cervello si nutre di novità ambientale. Dunque, qual è il prodotto di quest'area cerebrale? Fondamentalmente, simulazioni della realtà.
Da dove vengono le idee
Una delle funzioni dell'inconscio è quella creativa, connessa all'immaginazione e al sogno. Il fatto stesso che la nostra mente sia in grado di rievocare un'immagine o un suono è cruciale per il funzionamento del nostro intuito. Il fatto che, in talune situazioni, questa rievocazione sia addirittura necessaria e spontanea, è davvero curioso.
Prendiamo due esempi: i sogni e le allucinazioni.
Nella nostra coscienza c'è una sorta di barriera sensitiva, una soglia che stabilisce se uno stimolo è abbastanza nitido da essere reale. Al di sotto degli stimoli reali, il nostro cervello è tutto un rumore di echi di stimoli precedenti provenienti sia dall'esterno che dall'interno. Quando sogniamo, o quando abbiamo allucinazioni (esperienza abbastanza rara in assenza di patologie, stati di coscienza estremi oppure uso di sostanze), ciò che accade è che la barriera sensitiva si abbassa e lascia passare stimoli non reali. Quando sogniamo o abbiamo allucinazioni, stiamo assistendo al rumore di fondo dei nostri circuiti.
È proprio per questo motivo che, per stimolare la produzione di idee ed intuizioni, abbiamo bisogno di nutrire quel rumore di fondo, facendo nuove esperienze e, poi, avere dei momenti di privazione sensoriale, cioè situazioni che spingono la barriera sensitiva a diventare meno selettiva, proprio perché il rapporto segnale/rumore dei nostri sensi è molto basso. Questo favorisce l'affiorare di idee, ispirazioni, intuizioni.
Proprio per questo motivo, la noia è uno stato comprovatamente fertile in termini di idee ed intuizioni, ed è un vero peccato che il nostro tempo ne sia sostanzialmente privo, almeno se ci abbandoniamo alla disponibilità ininterrotta di stimoli mediatici.
Ma che cosa sono esattamente le idee?
Tutti gli esseri umani fanno, di tanto in tanto, questa esperienza: di fronte a un problema, ci si scervella per ore senza successo. Durante un momento di pausa e svago, improvvisamente ci vengono in mente una serie di possibili soluzioni al problema. Non c'è essere umano che non abbia sperimentato il sacro potere di una doccia nell'ispirare le frasi giuste che avremmo dovuto usare per vincere una litigata. È esattamente di questo che stiamo parlando: stimolo forte, tanta eco, privazione sensoriale, l'eco riaffiora.
Nel mezzo, c'è stata un'elaborazione inconscia, che il nostro cervello fa in automatico mentre
- Facciamo attività fisica
- Dormiamo
- Meditiamo
- Ci annoiamo
- Ci divertiamo
Il funzionamento di questa elaborazione inconscia è abbastanza semplice, a pensarci bene. Noi rivediamo i nostri ricordi tutto il tempo e, ogni volta che li consultiamo, il pensiero ne simula delle varianti. A dirla tutta, il pensiero è nato proprio così: per minimizzare il numero di azioni necessarie, simulandole in un ambiente (quello della fantasia) in grado di ipotizzare realtà, più o meno consistenti, diverse dall'attuale.
Ora, possiamo stare a guardare questo processo, focalizzandoci su di esso e stimolandolo attivamente, oppure possiamo lasciarlo scorrere come un task in background. Il bello è che, se optiamo per la seconda soluzione, verosimilmente nel frattempo faremo altro, quindi staremo involontariamente alimentando quel task con stimoli che, apparentemente, non c'entrano niente con il compito da svolgere, ma che in realtà forniscono ai nostri circuiti categorie e strutture nuove, aprendo percorsi che finora non abbiamo esplorato.
In effetti, è proprio così che ci si sente quando si ha un'intuizione, come se due neuroni che non si erano mai visti prima, si fossero incontrati per caso e scambiati informazioni importantissime che prima erano solo parziali, da entrambe le parti. A quel punto, abbiamo una nuova ipotetica soluzione da sottoporre al vaglio della realtà.
Allenare tecnica e creatività
Esaurita la spiegazione neuroscientifica, possiamo tornare al mestiere dello sviluppatore web. Abbiamo detto che, se vuoi fare il programmatore, queste due qualità ti servono entrambe, quindi, come fare a rinforzarle?
Il consiglio che vuol essere il fulcro di questo articolo è di mettere le qualità l'una al servizio dell'altra.
Proprio come un chitarrista, dopo anni di esercizi ripetitivi e sempre più complessi, potrà mettere la sua tecnica al servizio di un bellissimo assolo o di una ritmica coinvolgente, anche un developer, dopo aver padroneggiato l'if, lo while e il for, può metterli al servizio di un'intuizione per risolvere un problema.
D'altra parte, così come un musicista può sperimentare nuovi modi di esercitarsi per migliorare le sue capacità, anche un programmatore informatico può usare la creatività per produrre nuovi esercizi, nuovi esperimenti ed, infine, nuove tecniche innovative per lavorare meglio e produrre software di qualità migliore.
L'alternanza tra mezzi e fini
Oscillando tra questi due poli, ci rendiamo conto di assistere ad un ciclico scambio di ruoli tra i due: quando la creatività è il fine, la tecnica è il mezzo, e viceversa.
Obiettivo funzionale o artistico
In base al contesto, potrà capitare di produrre software di natura funzionale, come tutto il software di cui solitamente si parla (CRM, ERP, SCADA, HIM e via discorrendo, più tutto il software che controlla e governa oggetti fisici come automobili, robot, etc…), oppure, forse più raramente, di software finalizzato a scopi artistici, come software applicato all'arte generativa, o più semplicemente software di presentazione, cioè atto ad illustrare in maniera efficace e accattivante qualcuno o qualcosa. In questa categoria rientrano i toolkit di componenti grafici, i framework di stili e temi, i siti web che pubblicizzano prodotti o aziende, etc…
 Questione di prospettiva
Questione di prospettiva
Che si abbiano inclinazioni prevalentemente analitiche o creative, guardando "dall'altra parte" si sarà portati a considerare le competenze mancanti come un male necessario, cioè un qualcosa da acquisire, più o meno malvolentieri, per poter servire il più alto scopo di esprimere le qualità che invece fanno parte della propria indole.
Il nostro invito è quello di cercare sempre di "collocarsi" nel corpo calloso, cioè di vedere le competenze e le indoli personali come due diversi approcci all'elaborazione di informazioni, ma focalizzandosi sul traffico delle stesse, che sono invece le vere protagoniste della nostra produzione e del nostro lavoro perché, indipendentemente da come li trattiamo e da cosa ne deriva, sono proprio i dati che nutrono il processo analitico e tecnico quando assumono la forma di schemi e nozioni, e il processo creativo e intuitivo, quando assumono la forma di relazioni e trasformazioni.